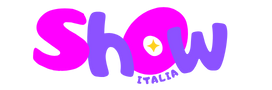Tra il 1945 e il 1951 l’Italia visse un momento storico, irripetibile. Sulle macerie della guerra, tra la miseria e la volontà di rinascita, nacque un linguaggio cinematografico destinato a cambiare la storia della settima arte, il Neorealismo.
Una corrente pensiero più che un movimento organizzato, che trasformò la macchina da presa in uno specchio capace di restituire il volto autentico di un Paese segnato dal dolore e ferito, ma vivo, vibrante nel suo desiderio di riscatto.
Il cinema come testimonianza
Liberatosi dal fascismo e dall’occupazione tedesca l’Italia degli anni immediatamente successivi alla guerra era attraversata da un veemente bisogno di verità. Gli studi di Cinecittà erano distrutti, le risorse economiche chiaramente scarse, ma la spinta morale e creativa era enorme.
È in questo contesto che registi vengono Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Luchino Visconti e Giuseppe De Santis scelso di raccontare l’Italia reale, quella fatta di stradine sterrate, borgate e campagne, in cui le voci degli ultimi erano le uniche ascoltate: operai, contadini, donne, bambini, anziani.
Un cinema, quello neorealista, decise a voltare le spalle ai salotti borghesi e alle scenografie fastose per abbracciare le macerie di Roma oi vicoli di Napoli. Con l’indimenticabile Roma città apertaRossellini inaugurerà una nuova grammatica cinematografica fondata su riprese di esterni, attori non professionisti, l’uso del dialetto e una narrazione frammentatafatta di ellissi e silenzi. Ed ecco che la realtà non veniva più raccontata, ma mostrata, in tutta la sua limpida crudezza.

D’altronde fu il Neorealismo a rompere definitivamente il legame, fino a quel momento strettissimo, tra cinema e finzione. Il suo linguaggio si nutriva di spontaneità e improvvisazionedi volti veri (e quale volto più vero di quello dell’intensa Anna Magnani?) e luoghi reali.
I registi erano decisi ad allontanarsi dal glam e dalle immagini patinate ereditate dal cinema degli anni Venti e Trenta, così come dalle grandi star ipnotiche come Greta Garbo e Rodolfo Valentino; bramavano l’autenticità come gli assetati bramano l’acqua.
E basta nominare due esempi per far capire tutta la forza delle loro intenzioni. In Ladri di biciclette (1948) De Sica raccontò la disperazione di un padre che, nella Roma del dopoguerra, cerca la sua bicicletta rubata, indispensabile per lavorare. In La terra trema Visconti fece recitare veri pescatori siciliani trasformando il romanzo verghiano in un affresco umano e sociale.
La censura e la fine di un sogno
Il successo internazionale dei film neorealisti (premiati a Cannes ea Hollywood) non bastò a proteggerli dalle pressioni interne. Dal 1947, con l’esclusione delle sinistre dal governo, il clima politico cambiò. La Legge Andreotti del 1949 introduce un controllo sui finanziamenti e vietò film ritenuti “diffamatori per l’immagine dell’Italia”.
Alcune opere, vieni Ladri di biciclettefurono censurati o ostacolati. E il pubblico non si oppone particolare resistenza. Si era all’inizio degli anni Cinquanta, l’Italia non desiderava altro che lasciarsi alle spalle le brutture della guerra e guardare avanti. Il pubblico, stanco di vedere miseria anche sullo schermo, si orientò verso il neorealismo rosadove la realtà si colorava di romanticismo e ironia. Arriva il film Pane, amore e fantasia segnarono la transizione verso la commedia all’italiana.
Pur essendo durato pochi anni, è indubbio che il Neorealismo abbai lasciato un’impronta indelebile nel cinema italiano. Cambiò per sempre il modo di intendere il cinema, ispirato registi della Nouvelle Vague come François Truffaut (come dimenticare Fino all’ultimo respiro?)Satyajit Ray e Martin Scorsese. Fu, in sostanza, la dimostrazione che l’arte può nascere anche dalle ceneri di una società e che la verità (quando viene raccontata con la brutale onestà delle immagini) ha la forza di attraversare il tempo.